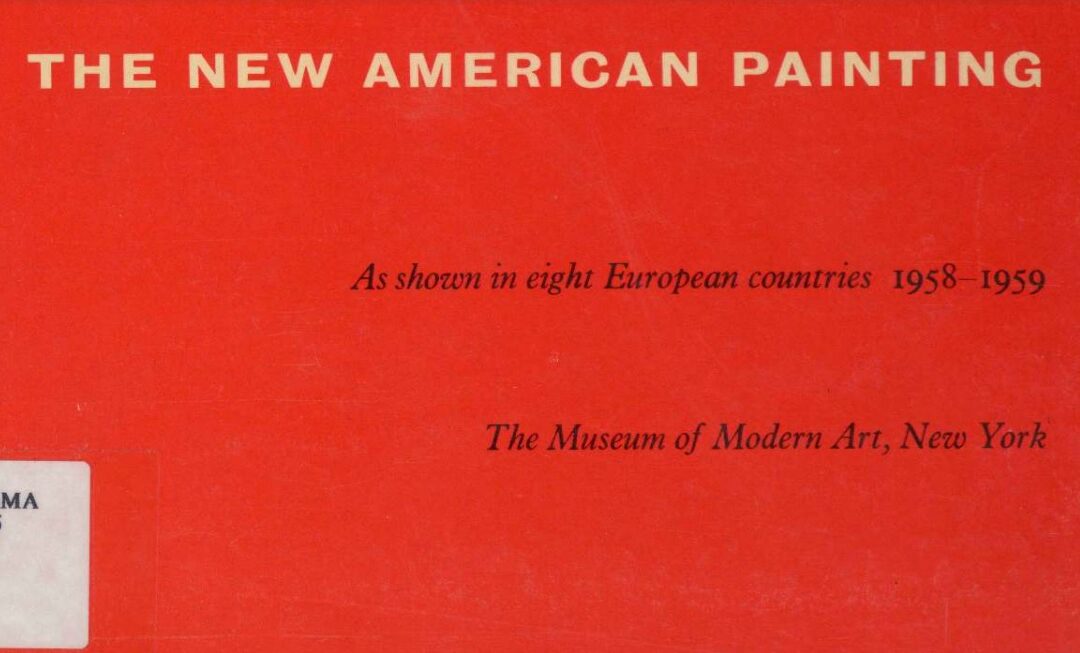da Roberto Grandi | 6 Set, 2021 | Bologna, Politica
Per tutto il tempo passato insieme.
Per le osterie, dentro e fuori porta, dove si beveva, fantasticava e progettava la vita. E tanta musica.
Per l’università, piantata al tuo centro da 900 anni, dove ho insegnato per decenni a migliaia di studentesse e studenti e promosso la sua internazionalizzazione.
Per chi in questi decenni con competenza, passione e sacrifici, ha usato la creatività per arricchire la tua offerta culturale, spesso in condizioni precarie.
Per gli spazi culturali diffusi di Bologna Sogna e il tempo che ho trascorso nei tuoi musei, teatri, cinema, biblioteche, circoli, e che mi ha dato tanto. Anzi, tantissimo.
Per il welfare, che dai primi asili nido l’ho visto allargarsi sempre più a tutte le fasce della popolazione.
Per avere reso democratico il digitale, con la rete Iperbole.
Per le prime pedonalizzazioni, che hanno creato molti mal di pancia.
Per la trasferta all’Olimpico del 1964, dove ho gioito per lo scudetto, e per le sfide di Basket City.
Per quando Umberto Eco proseguiva la lezione al bar in mezzo agli studenti.
Per il tuo futuro.
Per un futuro in cui accanto al dialogo digitale vi siano spazi sempre più liberi per stare insieme in presenza, con tempi più lenti tra parole, visioni, musica, davanti a un bicchiere.
Per un futuro con Unibo sempre più al vertice nella didattica e nella ricerca, sempre più attrattiva e in grado di trattenere qui i talenti migliori.
Per un futuro in cui si aprano spazi e residenze ai creativi, si elimini il precariato, si valorizzi la creatività artistica e quella delle industrie culturali.
Per un futuro in cui musei, teatri, cinema e biblioteche si aprano sempre di più a chi oggi non li frequenta.
Per un futuro in cui il welfare sociale si accompagni a quello educativo e culturale, dai laboratori didattici per giovani alle occasioni di socializzazione culturale per la popolazione fragile, anziana, sempre più sola.
Per un futuro in cui saremo capitale del più grande centro di calcolo nella nostra Data Valley, e anche la città che utilizza questa innovazione per migliorare i servizi e rendere le cittadine e i cittadini capaci di usarli.
Per un futuro in cui sarai in grado di offrire un’accoglienza di qualità allargata all’area metropolitana.
Per un futuro di prossimità, vivibilità urbane e pedonalizzazioni ben curate, con attenzione a chi le frequenta, a partire da bambini e bambine.
Per un futuro in cui ci darai un nuovo scudetto e il basket trionferà in Europa.
Per un futuro in cui l’urbanistica parta dalle esigenze di tutte le fasce della popolazione e dove la funzionalità si coniughi con la bellezza.
Per un futuro sostenibile in cui ci siano meno muri e più rapporti umani.
Per un futuro in cui ogni persona che arriva dal mondo si senta tua cittadina.
Per un futuro in cui quando vedi da lontano San Luca, ti senti arrivato a casa.
Mi candido per una città sostenibile, mappa di desideri, diritti, innovazione, per una città che costruisca la sua storia sempre guardando al futuro.
Per te mi candido.
Bologna, dalla parte del futuro.
Roberto Grandi
Candidato capolista della lista Matteo Lepore Sindaco (elezioni Consiglio Comunale di Bologna 3/4 Ottobre).
Già docente universitario, Assessore alla Cultura (Comune di Bologna), Pro Rettore alle Relazioni Internazionali (Università di Bologna), Presidente Istituzioni Bologna Musei.
#LeporeSindaco
#ScriviRobertoGrandi

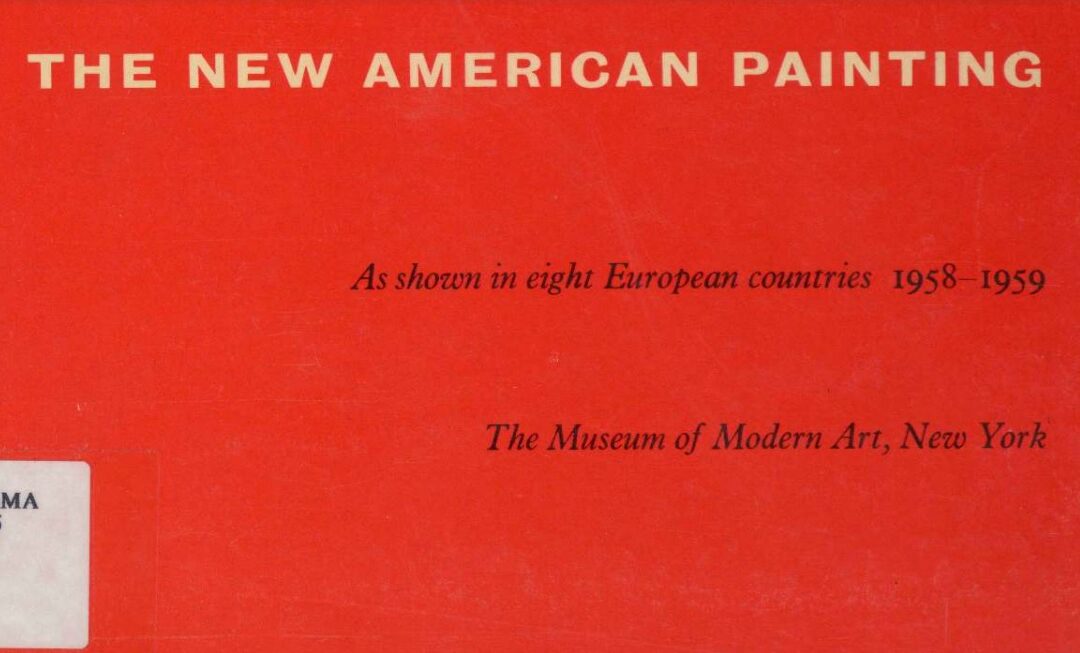
da Roberto Grandi | 22 Ott, 2020 | Cultura, Politica
Cia, Nelson Rockfeller e MoMA (Museum of Modern Art di New York) hanno anticipato negli anni ’50 ciò che oggi è sempre più di moda, il Soft Power.
Partendo dalla constatazione che la potenza internazionale degli stati si compone sia di aspetti materiali (risorse economiche e militari) che immateriali (cultura e valori) Joseph Nye nel 1990 ha parlato, per primo, di soft power. Lo ha definito come la capacità degli stati di aumentare la propria reputazione internazionale e l’attrattività e diffusione dei propri valori, modelli culturali, pratiche politiche senza la necessità di impiegare la forza né incentivi economici. La seduzione sostituisce la coercizione. La seduzione culturale va progettata in maniera meticolosa con buone dotazioni di mezzi e spesso attraverso operazioni coperte e segrete.
Nel 2015 una puntata della serie televisiva di Bottega Finzioni su Sky Arte, “Le Muse Inquietanti” a cui ho partecipato, era incentrata sul rapporto tra l’artista statunitense Jackson Pollock e la Cia.
Questa relazione, inserita nel contesto più ampio dei rapporti tra Cia, Moma e Espressionismo Astratto, è approfondita nel libro di Jennifer Dasal ArtCurious: Stories of the Unexpected, Slightly Odd, and Strangely Wonderful, appena pubblicato da Penguin Books.
La Cia, fondata nel 1947, includeva al proprio interno la divisione Propaganda Assets Inventory, costola della guerra psicologica posta in atto per promuovere opinioni e atteggiamenti favorevoli agli Stati Uniti nel clima di Guerra Fredda. Questa divisione della Cia ha creato nel 1950 il Congress for Cultural Freedom (CCF), una operazione dell’intelligence rimasta coperta fino 1966. Il CCF, che doveva apparire come legato a musei o organizzazioni artistiche, aveva uffici in 35 paesi, stipendiava decine di persone, pubblicava più di 20 riviste di prestigio, organizzava esposizioni d’arte, aveva un proprio servizio per la diffusione delle notizie e articoli di opinione, organizzava conferenze internazionali e ricompensava musicisti e altri artisti con premi e pubblici riconoscimenti.
Jennifer Dasal ricorda che “il museo maggiormente coinvolto fu il MoMA, grazie alla partecipazione di Nelson Rockfeller, politico, filantropo e futuro vice presidente degli Usa, con Gerald Ford. Rockfeller e il MoMA vanno mano nella mano, in quanto la madre è stata una delle co-fondatrici della istituzione, che Nelson chiamava Mommy’ Museum. D’altra parte Rockfeller aveva familiarità con i servizi segreti essendo stato coordinatore dell’ Inter-American Affairs for Latin America durante la seconda guerra mondiale, un’altra agenzia di propaganda”.
Grazie alla presidenza del del board del trustees del MoMA, Rockfeller rese possibile l’organizzazione di alcune delle mostre di maggior successo del CFF, compresa la grande mostra del 1958‒59 “The New American Painting.”
La Cia ha quindi usato l’espressionismo astratto come un’arma utile della guerra fredda e come prova della creatività, della libertà intellettuale e del potere culturale degli Usa.
Alla confluenza dell’Astrattismo e del Surrealismo, l’Espressionismo Astratto si diffonde negli anni ’50 e diventa emblema dell’arte americana. Manifestazione di un modo di sentire di una nuova generazione accomunata soprattutto dal rifiuto delle strutture politiche e sociali dominanti in quell’epoca. Si assiste a un cambiamento nell’iconografia astratta. Non più forme regolari, ma macchie, segni, sbavature e pennellate libere, basate su valori tonali puri e contrastanti, indice della individualità dell’artista, suo punto di vista emozionale.
La Cia lo individuò come un apporto specificamente americano all’arte moderna e lo promosse nel mondo all’oscuro degli artisti che lo portavano avanti che avrebbero rifiutato, se ne fossero venuti a conoscenza, di essere utilizzati come strumenti di propaganda del governo statunitense.
Gli obiettivi della Cia erano, in primo luogo, contrapporre al realismo sovietico figlio dell’ideologia comunista, un’arte aiconica e promuovere una visione degli Usa come terra della libertà di espressione, leader nelle arti e nella cultura contro un’Europa vecchia che stava perdendo il ruolo che aveva detenuto fino alla fine della seconda guerra mondiale.
L’ Espressionismo Astratto veniva propagandato anche per ripulire l’immagine culturale americana dal bigottismo maccartista: l’America è aperta alla cultura e all’arte della critica attraverso l’esportazione non
del mainstream conservatore ma della cultura liberal di New York. Una operazione di mistificazione propagandistica che funzionò bene.
La mostra principale e di maggior successo organizzata dal CFF sotto gli auspici del MoMA fu “The New American Painting” che viaggiò all’estero per un anno toccando le principali città dell’Europa occidentale, tra cui Londra, Parigi, Berlino, Milano. “Questo tour nei paesi amici degli Usa ricopriva una funzione strategica. Era un modo per cementare l’alleanza tra i partner della Guerra Fredda e promuovere la tanto decantata preminenza culturale degli Stati Uniti per la prima volta nella storia”.
Oggi a operazioni coperte di questo tipo da parte dei servizi segreti, che scopriremo solo in futuro, si accompagnano modalità più visibili e spettacolarii di soft power e diplomazia culturale come l’apertura di filiali dei grandi musei occidentali in paesi con tradizioni culturali molto diverse.

da Roberto Grandi | 16 Set, 2020 | Politica, Vita
Quanto la pandemia ha cambiato la nostra vita? Come paese usciamo dalla pandemia più uniti o più divisi?
A queste domande ha risposto un sondaggio del Pew Research Center che ha interessato 14 tra i paesi (Europa, Nord America, Australia, Giappone, Corea del Sud) economicamente più avanzati.
I 14 paesi hanno affrontato il Covid-19 in tempi diversi adottando misure differenti, dal lockdown dell’intera nazione a interventi molto meno drastici. Queste diverse scelte politiche hanno influenzato la percezione del cambiamento che è intervenuto nella nostra vita? La mediana di tutti paesi afferma che il 58% delle popolazioni ha percepito un grande cambiamento e il 42% nessun cambiamento o una modifica molto lieve.
La mediana copre, al proprio interno,. situazioni tra loro molto diverse. I paesi in cui la percezione di un grande cambiamento ha interessato almeno i due terzi della popolazione: Corea del Sud (81%), Svezia (71%), Usa (67%), Regno Unito (66%), Giappone (65%), Canada (64%). La percezione di cambiamento, sempre maggioritaria ma con percentuali minori, ha interessato anche Spagna (60%) e Italia (56%).
In sei paesi almeno la metà della popolazione ha affermato che la propria vita non è cambiata molto: Danimarca (73%), Germania (61%), Olanda (54%), Francia e Australia (53), Belgio(51%).
Non è possibile individuare una corrispondenza meccanica tra le scelte adottate dai governi e la percezione di cambiamento, ma pur con qualche eccezione è possibile ipotizzare che l’assenza di misure rigide come il lockdown abbia incrementato piuttosto che diminuito il senso di un grande cambiamento.
Se andiamo più in profondità vediamo che la percentuale di donne che ha affermato che la loro vita è cambiata durante il coronavirus è superiore a quella degli uomini in tutti i 14 paesi, con differenze percentuali inferiori all’8% in Olanda, Germania, Danimarca, Spagna, Corea del Sud. Percentuali superiori del 15% in Svezia, Stati Uniti e Francia. Negli altri paesi le differenze sono state tra il 10% (in Italia) e il 12%. La maggiore percezione di cambiamento delle donne è stata determinata sia dall’essere più degli uomini lavoratrici part time (a cui è stato spesso sospeso il lavoro) sia dall’incremento generalizzato a tutti i paesi del lavoro domestico.
Nei mesi scorsi si è poi parlato molto di come la pandemia abbia unito di più i paesi al proprio interno nel momento del pericolo. Anche le opinioni su questo tema sono molto divise e contrapposte. Il 46% afferma infatti che il paese è più unito, il 48% più diviso.
I paesi in cui prevale chi pensa che il paese sia oggi più unito sono: Danimarca (72%), Canada (66%), Svezia (58%), Corea del Sud (56%), Australia (54%). Il paese la cui popolazione pensa che la gestione della crisi Covid-19 abbia ampliato le divisioni interne è gli Stati Uniti dove ciò che sta succedendo anche oggi è una ulteriore conferma. La percezione di una maggiore divisione ha coinvolto gli altri paesi, con percentuali superiori al 50% in Spagna (59%), Belgio(55%), Germania e Italia (54%), Olanda (53%).
Dai risultati di questa indagine internazionale emerge che le percezioni sulle conseguenze della lotta al coronavirus sono molto diverse da paese a paese e che dipendono da variabili ideologiche, sociali, personali incrociate con gli interventi portati avanti nei singoli paesi.

da Roberto Grandi | 29 Gen, 2020 | Media, Politica
Salvini ha nazionalizzato una competizione elettorale regionale trasformandola in un referendum su di sé. Questa strategia di ribaltamento ha una lunga storia nelle campagne elettorali. Fermiamoci all’Italia negli ultimi venti anni.
Un primo esempio di ‘nazionalizzazione” di una campagna regionale con voto diretto del Presidente si ebbe il 16 aprile 2000. Berlusconi, di nuovo alleato con la Lega, ribaltò il carattere regionale con una campagna incentrata sulla “Scelta di Campo” nazionale contro la Sinistra. D’Alema, Presidente del Consiglio, accettò la sfida, fidandosi dei sondaggi e sperando così di legittimare con un voto la sua Presidenza. Quindici le Regioni al voto, di cui 11 governate dal centrosinistra. D’Alema dichiarò, incautamente, che avrebbe vinto 10 a 5 o addirittura 11 a 4. Questo referendum sui due leader finì 8 a 7 per Berlusconi. Il giorno successivo D’Alema si dimise. Subentrò il governo Amato.
Quattordici anni dopo, il 25 maggio 2014, si tennero le elezioni europee. In questo caso sia il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che Beppe Grillo snaturarono la portata europea di queste elezioni e le trasformarono in un referendum, amplificato dai media, su di loro. Si ipotizzava un testa a testa, invece il Pd di Renzi prevalse con quasi il 41% verso il M5S di Grillo al 21%.
Questa vittoria ha probabilmente indotto Renzi a personalizzare anche il successivo referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. I manuali di comunicazione politica mettono in guardia da ripetere un colpo vincente. Troppe sono le ‘variabili ambientali’ che influiscono sui risultati dei referendum personalizzati. L’esito lo ricordiamo. Renzi ottenne di nuovo il 41%, ma questa volta di fronte aveva il 59% di no. Come D’Alema sedici anni prima, il giorno successivo annunciò le dimissioni da Presidente del Consiglio.
L’ultimo esempio è fresco fresco.
Matteo Salvini, dopo l’incidente di percorso delle dimissioni balneari che non hanno provocato l’auspicata e attesa caduta del governo, è stato costretto a cercare un’altra occasione per dare la spallata a Conte, senza attendere la scadenza elettorale naturale. Le elezioni regionali in Umbria e Calabria non avevano la portata politica sufficiente per fare credere che avrebbero provocato la caduta del governo. L’appuntamento perfetto era il voto in Emilia-Romagna. Le elezioni europee avevano visto l’avanzata della Lega e l’arretramento del Partito Democratico e dei grillini anche in Emilia Romagna, che è così diventata una Regione contendibile. Salvini ha deciso di non seguire il modello vincente di Giorgio Guazzaloca che, venti anni prima, aveva conquistato il comune rosso di Bologna con una proposta di centrodestra a guida civica. La ragione è chiara. Se infatti il candidato presidente del centro destra a questa elezione fosse stato un civico centrista, sarebbe stato impossibile per Salvini nazionalizzare l’elezione trasformandola in un referendum su di sé e, come effetto riflesso, contro il governo. Definire la strategia significa fare una scelta e rimanervi fedele per tutta la campagna. E’ ciò che Salvini ha fatto. Tutto deriva da questa scelta, imposta ad alleati in parte riottosi ma subalterni. Conseguente è stata la scelta di una candidata della Lega, Lucia Borgonzoni, con cui costruire un gioco di squadra in cui ciascuno aveva un ruolo. Mediaticamente preminente quello di Salvini che, forte dei sondaggi, ha fatto due mesi di campagna intensa, on line e off line, per nazionalizzare e personalizzare al massimo le elezioni regionali. Da questo punto di vista Salvini ha avuto successo e tutti i media hanno contribuito a dipingere questa elezione come un referendum su Salvini e sul destino del governo Conte. Questa scelta di Salvini ha indotto il centrosinistra a fare l’unica scelta possibile. Accettare sì la sfida della personalizzazione, accompagnata però a una deideologizzazione e regionalizzazione del voto. Da ciò è conseguita la campagna tutta incentrata su Stefano Bonaccini quale buon amministratore che chiede il voto non a nome dei partiti, ma per quello che aveva fatto e la competenza che aveva messo in campo. Da una parte, la nazionalizzazione della campagna elettorale, dall’altra la sua regionalizzazione. Su questi binari si sono instradate le campagne parallele di Salvini e Bonaccini (con Lucia Borgonzoni meno mediaticamente esposta) che hanno battutto palmo a palmo la regione. Questo modello di campagna elettorale è stato a un certo punto messo alla prova dalla presenza di un terzo attore imprevisto, anche nei manuali. Il movimento della sardine che, dal punto di vista della strategia di Salvini, ha depotenziato
il ruolo centrale di vicinanza al popolo attribuito alle piazze piccole, medie, grandi che riempiva con una regolarità, amplificata anche eccessivamente dai media. On line e off line dominati da Salvini che ogni sera aveva prenotato il suo spazio sui notiziari nazionali. Da un certo momento in avanti, però, le piazze di Salvini sono diventate, anche mediaticamente, le piazze di Salvini e delle sardine. Paradossalmente Salvini ha contribuito a consolidare il ruolo delle sardine come movimento che proponeva un linguaggio e valori contrapposti al suo modo muscoloso di fare campagna elettorale. Salvini non era più il padrone televisivo delle piazze, ma doveva accettare una coabitazione. Ai servizi televisivi dedicati alla presenza di Salvini in strada si accompagnavano servizi sulla presenza delle sardine negli stessi luoghi. A volte più numerose. La strategia di Salvini doveva mantenere una propria coerenza anche perché era tardi per qualsiasi cambiamento. Gli ingranaggi rodati e routinari della campagna permanente salviniana erano stati pensati contro i partiti e i suoi esponenti, non contro un soggetto ibrido e sfuggente come le sardine e un candidato che enfatizzava più tratti civici che partitici. E’ come se grumi di sabbia si fossero inseriti in un ingranaggio rodato che ha cominciato a fare qualche giro a vuoto. Salvini ha quindi deciso di spingere ancora di più, di stressare la macchina della propaganda estremizzandone ulteriormente i contenuti e, soprattutto, le modalità di comunicazione. In politica è noto che a una sollecitazione si hanno sempre delle risposte. Bisogna prevedere con certezza che le risposte positive di adesione e mobilitazione non superino quelle di rifiuto e contrapposizione. Bisogna evitare che le azioni creino degli anticorpi imprevisti. Questo è ciò che accade specialmente nelle elezioni trasformate in un referendum, in cui uno solo vince. Si va a votare a favore di un candidato e si va a votare anche contro un candidato.
L’esito delle urne ci ha detto che Salvini con la sua campagna ha sì mobilitato il proprio elettorato ma ha anche, contemporaneamente, contribuito a mobilitare un elettorato motivato dalla necessità di fermarlo. Bonaccini con la sua campagna ha mobilitato un elettorato più ampio di quello dei partiti che lo hanno appoggiato e ha usufruito anche del voto contro il ‘pericolo salviniano’.

da Roberto Grandi | 8 Mag, 2019 | Cultura, Politica, Vita
Nel mondo la maggioranza delle persone percepisce un incremento della migrazione nel proprio paese. Questo fenomeno è giudicato positivo da molti, ma non da tutti. Il contesto nazionale, l’età, il livello di istruzione e l’ideologia influenzano questo giudizio.
Il Pew Research Center ha intervistato oltre 30.000 persone in 27 paesi che ospitano più della metà dei migranti del mondo.
Il 70% di questa popolazione dichiara che negli ultimi venti anni la diversità indotta dai processi migratori nel proprio paese è effettivamente aumentata. La mediana in Europa è superiore: si colloca all’82%. La più elevata è tra i greci (92%) che in questi ultimi anni sono stati al centro di vari flussi di immigrazione. Anche gli italiani hanno una percezione elevata (81%), non superiore, però, agli svedesi, tedeschi, spagnoli, inglesi, olandesi che si collocano tutti tra l’80% e l’88%. Percentuale analoga tra i paesi non europei: Canada, Corea del Sud, Australia, Indonesia. Polonia (61%) e Ungheria (54%) hanno invece percentuali ben al di sotto della mediana europea.
A chi ha percepito un incremento della diversità interna al proprio paese è stato domandato se lo giudica un fatto positivo o negativo.
Diversamente da come possiamo pensare dal nostro osservatorio italiano, la mediana a livello mondiale dei favorevoli a una maggiore eterogeneità della popolazione interna è 45% contro 23% che la giudica in maniera negativa. Negli Stati Uniti, dove Trump ha imposto alla agenda politica la costruzione di un muro che separi il proprio paese dal Messico, la distinzione tra favorevoli e contrari è ancora più marcata: 61% verso 17%.
Gli Europei sono più ambivalenti. In soli due paesi tra quelli che più percepiscono l’incremento della diversità la percentuale di chi la considera negativamente ( Grecia 62% e Italia 45%) supera quella di chi la considera positivamente (17% e 26%). Negli altri paesi europei in cui i cittadini, come abbiamo visto, hanno una elevata percezione dell’aumento della diversità, simile all’Italia, i pareri positivi superano invece quelli negativi. Olanda, di poco, 36% vs. 41%. Svezia e Germania rispettivamente 30% e 32% contrari contro 56% e 50% a favore. Chi smentisce con più decisione l’esistenza di una correlazione tra alta percezione di incremento di diversità interna e alta percentuale di giudizi negativi sono il Regno Unito e la Spagna con 20% e 23% contrari e ben 62% e 58% favorevoli. Abbiamo visto che in Polonia e Ungheria la percezione dell’incremento della diversità è tra le più basse in Europa (61% e 54%); a questo corrisponde un quasi equilibrio tra contrari (25% e 27%) e favorevoli (28% e 20%).
Al di là della variabile determinata dal contesto di ogni nazione quanto variabili quali l’età, l’ideologia e i livelli di istruzione incidono sulla propensione alla accettazione o al rifiuto di una maggiore diversità nel proprio paese?
In più della metà dei paesi del sondaggio i giovani esprimono giudizi più positivi degli anziani. In Italia, per esempio, la percentuale dei favorevoli decresce passando dai 18-29 anni (44%), 30-49 anni (32%), oltre 50 anni (17%). Il gap tra la percentuale a favore tra i più giovani e i più anziani è superiore a 20 punti percentuali in Italia, Australia, Brasile, Messico, Regno Unito e Giappone.
Un’altra variabile individuata è l’auto collocazione politico-ideologica.
In 11 dei 18 paesi dove questa variabile è stata analizzata, chi si definisce di sinistra è più favorevole all’incremento della diversità interna rispetto a chi si colloca a destra. Tra chi si riconosce nei partiti di estrema destra del proprio paese la distanza maggiore è in Svezia: contrari 73%, favorevoli 24%. Un divario tra il 24% e il 27% in Germania (56% contrari, 29% favorevoli), Olanda (50% vs., 24%), Regno Unito (68% vs. 43%), Francia (52% vs. 28%).
L’altra variabile che incide sulla visione positiva o negativa dell’aumento della diversità interna è il livello di istruzione.
In 19 dei 27 paesi del sondaggio le persone con livelli di istruzione superiore esprimono un parere più positivo rispetto a chi ha una istruzione inferiore. In Europa la sola eccezione è l’Ungheria dove questa variabile non ha alcuna incidenza. La maggiore significatività, sempre in Europa, è stata individuata in
Spagna (a favore della diversità il 50% dei meno istruiti e il 74% dei più istruiti) e in Germania (44% vs. 65%). Una incidenza significativa del livello di istruzione è stata individuata anche in paesi con un basso giudizio positivo sull’incremento della diversità interna. In Grecia la percentuale dei favorevoli tra i meno istruiti è 14% verso 24% favorevoli; in Italia 24% verso 40%; In Polonia 25% vs. 38%.
In conclusione, la maggioranza delle persone è consapevole che i sempre più intensi flussi migratori aumentano la diversità interna al proprio paese. A questa constatazione seguono giudizi positivi o negativi. Questi giudizi sono influenzati dai contesti nazionali, dall’età, dal livello di istruzione e dalla collocazione ideologica. La Grecia e l’Italia sono i due paesi in cui il contesto nazionale incide più profondamente sulla prevalenza dei giudizi negativi rispetto alla influenza delle altre tre variabili.

da Roberto Grandi | 30 Apr, 2019 | Media, Politica
Il Presidente per caso di una serie televisiva batte il miliardario re del cioccolato e proprietario di Canale 5. Volodimir Zelensky è il nuovo Presidente della Repubblica Ucraina con il 73% dei voti contro il 24% all’attuale Presidente, Petro Poroshenko.
Al di là delle semplificazioni e delle facili battute su un comico che diventa Presidente quasi per caso, replicando in tre mesi l’ascesa analoga nella serie televisiva, queste elezioni insegnano molto sulle campagne elettorali definite post-moderne o post-democratiche.
Primo, il contesto. I sondaggi mostravano da tempo che solo il 9% della popolazione aveva fiducia nel governo e che l’avversione ai politici e al sistema politico era generalizzata.
Come in altri casi – ricordiamo la discesa in campo di Berlusconi 25 anni fa – gli elettori erano pronti a dare fiducia a chi veniva percepito come nuovo, rispetto alla vecchia politica.
Zelensky è al terzo anno della serie televisiva satirica di successo, Servo del Popolo, oggi anche su Netflix. Un insegnante di storia, interpretato da Zelensky, diventa Presidente in seguito al successo virale sui social media di una sua invettiva esplosiva contro la corruzione dei politici. A questo link un trailer della serie.
Significativo il post di tre settimane fa di My Tara, in cui il commento positivo si divide tra l’apprezzamento per la serie e quello per il presente e il futuro dell’interprete: The actual film is much better and clever than this compilation. And Ze is not only a good actor. He’s a successful business man, a true patriot and represents a new generation. Hopefully, he will have balls to fight corruption! And would start from building the roads around the country!
Avvicinandosi le elezioni, Zelensky fonda il partito Servo del Popolo, dal titolo della serie televisiva, e a Capodanno annuncia la sua candidatura. I sondaggi mostravano che gli elettori cercavano qualcuno nuovo, fuori dai giochi della politica che fosse disposto a metterci una faccia credibile. Ecco perché Zelinsky ha portato avanti una campagna elettorale anticonvenzionale con l’obiettivo strategico di essere percepito come nuovo e credibile. La brevità della campagna era un vantaggio, perché giustificava la mancanza di un programma completo ed elaborato.
Zelisnsky si è mosso online e offline tenendo fede allo slogan: “Niente Promesse, Niente Delusioni”.
Con l’aiuto di giovani volontari ha gestito la campagna elettorale attraverso un flusso costante di post, soprattutto brevi video, su Facebook, You Tube e Instagram (dove ha oltre 4 milioni di follower contro i 250.000 di Poroshenko). L’obiettivo era costruire una immagine positiva. Lo si vede allenarsi in palestra, scherzare con gli amici e mentre viene aggiornato da un team di consulenti che, si dice, lo seguiranno una volta diventato Presidente. La mancanza di esperienza è infatti l’accusa che tutti gli avversari gli muovono, non rendendosi conto che per molti elettori è proprio questa assenza la garanzia del suo essere effettivamente nuovo e fuori dai circoli della politica. Ha anche richiesto on line agli elettori di inviare idee per il programma elettorale.
Off line ha scelto una campagna che accentuava ancora di più la sua distanza dalla politica tradizionale. Rarissime conferenze stampa, pochissime interviste, sempre attento a non prendere impegni politici specifici, niente comizi. Ha scelto di girare il paese con uno spettacolo, insieme al suo gruppo teatrale “Kvartal 95”.
Al contrario del suo avversario Poroshenko, capo del partito Solidarietà, in politica e negli affari dagli anni ’90, che ha negli ultimi tempi abbracciato una posizione ultranazionalista contro la Russia di Putin, fino all’appoggio entusiasta alla proclamazione della indipendenza della Chiesa ortodossa ucraina da quella moscovita. Poroshenko ha tenuto comizi tradizionali, si è appoggiato alla rete degli amministratori locali e è stato una presenza costante negli studi televisivi, da cui Zelensky si è tenuto lontano.
Zelensky ha accettato di fare un solo dibattito con Poroshenko, a due giorni dal voto, imponendo come luogo lo stadio olimpico di Kiev.
La percezione degli ucraini al termine della campagna elettorale è stata quella di una contrapposizione tra vecchio e nuovo. Tra ciò che già conoscevano e che rifiutavano e l’incognita di chi non prometteva per non deludere.
Poco hanno contato i legami con il chiacchierato oligarca Ihor Kolomojskij, autoesiliatosi a Tel Aviv, proprietario della rete televisiva “1+1” che mette in onda la serie Servo al Popolo. La rete ha parteggiato esplicitamente per Zelensky presidente, soprattutto all’avvicinarsi del voto.
Questa campagna elettorale ha mostrato tratti comuni a molte campagne recenti, in cui la scelta è stata guidata più dalla stanchezza, dalla nausea e dal rifiuto della politica tradizionale (spesso fatta coincidere con la democrazia rappresentativa) che non dalla adesione a chiari e credibili progetti elettorali. In questa situazione la comunicazione politica utilizza tutti i media (dai social ai tradizionali) e le occasioni off line per costruire l’immagine di candidati che vengano percepiti come nuovi e non-politici. E’ un processo che spesso ha vita breve, perché chi oggi è nuovo il prossimo giro è già considerato vecchio. D’altra parte, tornando all’Ucraina, la Rivoluzione Arancione che aveva mobilitato le speranze di tanta parte della popolazione per un cambiamento radicale era stata, almeno in parte, costruita utilizzando tecniche proprie del marketing politico che non hanno garantito la soddisfazione delle speranze che avevano suscitato.